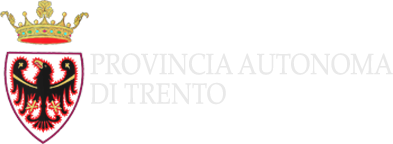Confessioni di oppiomani
Il il Centro studi Martino Martini a margine della mostra "Sapore di tè, profumo di oppio. Commerci, cultura, conflitti tra Europa e Cina dal XVIII al XX secolo" invita ad una serata con letture tratte da "I paradisi artificiali" di Baudelaire, "Il sogno di Coleridge" di Borges, "Kubla Khan" di Coleridge e attraverso accenni a Edgar Allan Poe, Emily Dickinson, Ada Byron, Karin Boye, Gregory Bateson che il professor Giuseppe O. Longo divagherà sui sentieri della letteratura, pa rlando anche della natura e degli effetti dell'oppio e del laudano.
Il professor Giorgio Vallortigara, direttore del Centro Mente-cervello di Rovereto, si innesterà nel discorso guardando il fenomeno dal punto di vista delle neuroscienze.
Il professor Riccardo Scartezzini, curatore della mostra, si soffermerà su aspetti storico/sociali.
Nel 1812 lo scrittore inglese Thomas De Quincey pubblicava sotto forma anonima un romanzo autobiografico avente per titolo Confessioni di un mangiatore di oppio.
Iniziava così una sorta di genere letterario che aveva al centro la pianta venuta dallOriente, il cui profumo inebriante faceva viaggiare la mente in terre sconosciute.
Loppio diventava il compagno della generazione dei poeti maledetti dell800, capaci di rovinarsi attraverso lassunzione di stupefacenti divenuti, al pari dellalcool, una vera e propria droga. Questa tradizione ebbe una fortuna letteraria notevolissima divenendo un rimando estetico piuttosto che una reale condotta di vita. Gli eccessi però, da Baudelaire ad Hemingway, hanno fatto sempre parte dellimmaginario dellartista e sono stati, volenti o nolenti, cause di grande ispirazione.
Oggi giustamente loppio viene considerato una droga. Tuttavia gli oppiacei vengono utilizzati in medicina e sostanze psicotrope trovano posto nello studio del cervello. Quali le frontiere da raggiungere, quali i limiti da non attraversare?
organizzazione: Centro Studi Martino Martini per le relazioni culturali Europa/Cina