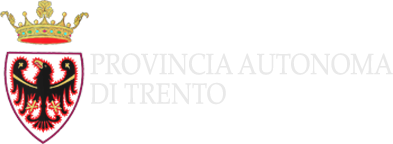Cuori di terra
Giorno della memoria. 27 gennaio 2008
Teatro dell'Orsa Reggio Emilia
Cuori di terra
Memoria per i sette Fratelli Cervi
progetto di narrazione/spettacolo
ideazione, drammaturgia e realizzazione Bernardino Bonzani, Monica Morini
ricerca musicale e composizione Davide Bizzarri (violino)
esecuzione musicale Claudia Catellani (piano), Giovanni Cavazzoni (contrabbasso)
si ringrazia per la ricerca del materiale documentale lIstituto Alcide Cervi di Reggio Emilia
In unaia di una corte contadina, sotto una barchessa o in una stalla, si potrebbe raccontare questa storia, il sacrificio di una famiglia reggiana unita come le dita di una mano. Così emblematica per il suo esito tragico, quella dei Cervi, rappresenta la storia di molte famiglie emiliane, di un popolo che matura una consapevolezza politica e sociale orientata verso i principi di solidarietà e di umanità, in un cammino di emancipazione che inizia sul finire del 1800 e si manifesta con lantifascismo e la Resistenza. Ma quello che rende più singolare la vicenda dei Cervi è la grande vitalità che si intravede; il coraggio, la capacità di iniziativa, lintelligenza, larguzia, il clima di allegria con cui la famiglia visse dal principio alla fine la sua tragedia.
Siamo partiti dalloralità del racconto, come se di bocca in bocca, si facesse filos sulla paglia, sotto le volte della stalla. Abbiamo incontrato una grande ricchezza di situazioni, tante figure parevano venirci incontro e trasmettere una speciale energia epica. A dar linfa al racconto, le parole dei libri di Alcide e Margherita Cervi, la visione delle lettere, dei documenti e degli oggetti del Museo, gli scritti di letterati e politici. Il lavoro, però ha preso cuore e vigore grazie alle testimonianze dirette e ai racconti, come quelli di Maria Cervi, figlia di Antenore. Il punto di vista dei narratori in scena è rispettivamente quello maschile e quello femminile, come se di volta in volta a parlare fossero gli uomini, papà Alcide e i suoi figli, o le donne della famiglia, la mamma Genoveffa e le nuore, sempre presenti, a volte più silenziose, ma pronte al sacrificio e alla continuità della vita, senza perdere il senso delle cose, dei sentimenti e forse anche della storia.
La ricerca sulla parola si intreccia a quella musicale, da cui riceve forza e sentimento. Le note che accompagnano lo spettacolo sono ispirate ai fatti raccontati, attingono alle suggestioni provenienti dalla musica contemporanea e, indietro nel tempo, alla tradizione dei Violini di Santa Vittoria. Fin dal 1700 infatti, nella bassa pianura reggiana, alcuni lavoratori stagionali si dedicarono, durante i tempi morti del lavoro nei campi, alla musica da ballo, creando uno stile originale grazie al miscuglio di tradizioni che in questa zona si incontravano: dalla musica austriaca, a quella magiara ed ebraica. Musica di festa, vitalità, movimento, come nellimbandigione di pastasciutta che la famiglia offre a tutto il paese per festeggiare il crollo del regime, allindomani del 25 luglio 1943.
A un uomo che domanda come si possa prevenire la guerra, Virginia Woolf, nel libro Le tre ghinee, risponde: Occorre narrare biografie. Quasi a suggerire che, nellimminenza di una guerra e perciò di migliaia di morti, lantidoto migliore è quello di raccontare delle storie di vita, dellunicità insostituibile di quelle vite, patrimoni che possono essere perduti per sempre. Nel nostro percorso di ricerca, mentre ancora raccogliamo i fili di questa storia, ci sentiamo di dire, con Maria Cervi, che ciò che più ci manca oggi, sono loro: Gelindo, Antenore, Aldo, Ferdinando, Agostino, Ovidio, Ettore. Vederli spuntare dietro ai salici, dai campi, tutti e sette con le falci sulle spalle, pronti a srotolare il loro miracolo di umanità.
organizzazione: Fondazione Museo storico in Trento