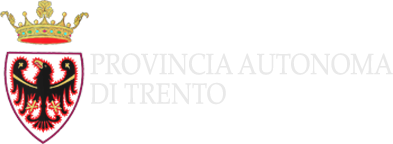Der Teufel recht natürlich
Festival Internazionale Wolfgang Amadeus Mozart 2005
«Der Teufel recht naturlich» (Il diavolo così com'è)
Mozart, Paisiello e gli Italiani: storia di unordinaria inversione di fortuna
Prima esecuzione assoluta
di Danilo Faravelli
con Milvia Marigliano
Musiche Marco Mantovani
Realizzazioni video Paola Castellucci
Regia Milvia Marigliano
Con "Der Teufel recht natürlich" ("Il diavolo così com'è"), Danilo Faravelli è alla sua quinta realizzazione teatrale ispirata alla vita e all'opera di Mozart. L'hanno preceduta: Intervista a Mozart (Teatro "Rosetum", Milano, 1991), Constanze. Una veglia non impossibile (Spazio "Zazie", Milano, 1999), Il dissoluto redento (Teatro di via Redi, Milano, 2001) e Mozart, Salieri e paralipomeni (Sala Capitolare della Basilica di S. Maria della Passione, Milano, 2004).
"Se un pittore volesse ritrarre il diavolo così com'è (der Teufel recht natürlich), potrebbe trarre ispirazione dal suo aspetto". Con queste parole Mozart, in una lettera inviata al padre il 22 agosto del 1781, cominciò a descrivere una delle sue più promettenti allieve viennesi, Josepha von Auernhammer. Il divertimento scenico musicale di stasera, operazione teatrale condotta sulla linea di confine che separa il mondo delle fantasie verosimili da quello delle verità non dimostrabili, è un'invenzione ispirata al turbine di irrazionalità che quel documento epistolare avrebbe potuto scatenare, se la donna in esso denigrata avesse mai potuto prenderne visione. È una fantasia ispirata alla vera storia di un amore non corrisposto o, peggio, corrisposto su piani tra loro debolmente comunicanti e comunque inconciliabili. È una storia d'amore nel contempo musicale e carnale, che nella delizia dei suoni trovò la strada del proprio sublimato trionfo e nella frustrazione del desiderio la dura irrevocabilità del proprio fallimento, una storia d'amore radiosa quanto angosciosa, che ebbe per protagonisti un giovane pianista compositore destinato all'immortalità e una giovane pianista, apprendista compositrice, capace di comprenderne e condividerne il genio al suo primo sgorgare.
Nella finzione teatrale, il personaggio di Josepha von Auernhammer, affidato ad una "mattatrice" del calibro di Milvia Marigliano, non nuova a ruoli di tale densità psicologica (memorabile la sua interpretazione delle Erodiadi di Giovanni Testori), viene cronologicamente collocato agli inizi dell'Ottocento, a Vienna, tra le pareti dell'austera scuola di musica da lei stessa fondata e di cui è direttrice. Obiettivo dichiarato del suo "progetto formativo" è la più completa squalificazione, quando non la vera e propria distruzione, dell'immenso patrimonio di capolavori lasciato in eredità ai posteri dal genio di Mozart, morto da una decina d'anni. Coinvolgendo in questa folle crociata i propri allievi (impersonati in scena dai membri del Quintetto "Concord" e dal soprano Anna Pellizzari), Josepha non intende semplicemente scatenare la campagna di purificazione estetica che, per puro rancore, dichiara di sentire necessaria sulla base di un certa idea di Bellezza musicale; ha piuttosto in mente di regolare un vecchio conto personale, rimasto in sospeso per troppo tempo. Vent'anni prima era stata allieva di Mozart, da poco trasferitosi a Vienna, e se n'era perdutamente innamorata. Questi non solo l'aveva respinta, ma aveva anche espresso per iscritto, in una lettera al padre (fuori finzione, quella summenzionata), i più ingenerosi apprezzamenti sulla sgradevolezza del suo corpo e sulla intollerabilità del suo carattere. La cosa, avesse avuto un corso naturale pur in tutta la sua mancanza di garbo, si sarebbe risolta nel classico caso di infelicità a senso unico che consegue ad ogni passione non corrisposta, ma, a complicare la storia d'amore, ci si era messa l'attrazione irresistibile provata dal maestro per la straordinaria musicalità che la povera Josepha, per quanto inguardabile e inavvicinabile, aveva mostrato di possedere sedendo al pianoforte. Così, in lui, genio sordo ai richiami di Venere ma non a quelli di Apollo, questo contraddittorio sentimento aveva fatto nascere l'idea di una composizione per due pianoforti (fuori finzione, la Sonata in Re maggiore KV 448/375a) con cui poter godere del talento dell'allieva senza nulla concederle eroticamente. Per due pianoforti, appunto, e non per la più abituale prescrizione del "suonare a quattro mani": per due pianoforti, affinché il più completo godimento musicale, consumandosi a distanza di sicurezza, potesse essere raggiunto con le dovute garanzie di metafisico e asettico ardore. Sul bruciante ricordo dell'umiliazione patita, Josepha dà sfogo ad un vortice di risentimento che travolge tutto ciò che incontra: i nobili frequentatori della sua scuola, la musica che chiede loro di eseguire, i volti dei fantasmi di un passato da cancellare, ai quali rivolge la parola come fossero presenti in carne ed ossa. Ma, alla fine, odio e amore si troveranno fusi in un groviglio inestricabile, a dipanare il quale varrà solo un'ambigua promessa di normalizzazione: quella sempre portata in dono dalla prospettiva di offuscamento e travisamento della realtà che lo scorrere del tempo, immancabilmente quanto inesorabilmente, sa garantire.
Tutto questo, sotto le luci del palcoscenico; ma chi fu, nei fatti, la donna rievocata dalla protagonista di "Der Teufel recht natürlich" ("Il diavolo così comè")?
organizzazione: Festival Internazionale W.A. Mozart a Rovereto