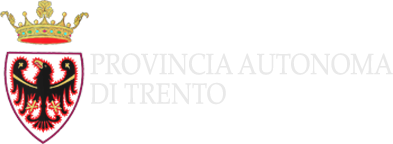Gli altopiani cimbri: resistere in quota
Con Fiorenzo Nicolussi Castellan. Introduce Massimo Libardi

Le Alpi, da ovest a est, a partire dal basso medioevo sono state oggetto di insediamenti di popoli germanici. Popoli pacifici alla ricerca di un futuro in una terra inospitale, una terra poco appetibile agli autoctoni; popoli che hanno saputo trasformare un territorio aspro in un ambiente, bensì avaro e duro, ma capace, comunque, di fornire, al prezzo di grandi sacrifici, il necessario per sopravvivere.
Popoli ora valorizzati e incentivati a presidiare il loro territorio, ora visti con sospetto se non addirittura oggetto di persecuzioni attraverso una politica di “pulizia etnica”. Popoli che hanno saputo coniare il territorio e lasciare un’impronta del loro operato e che oggi cercano di rimettersi in gioco ripensando a come vivere dignitosamente la montagna.
Una montagna, anche quella di Luserna, il cui paesaggio ha risentito fortemente dell’intervento dell’uomo: foreste di faggio rase al suolo per ricavarne carbone per alimentare i forni fusori dell’età del rame; un arcipelago di malghe al servizio dei principi vescovi e, recentemente, paesaggio di guerra nel corso del primo conflitto mondiale.
Ma nonostante molte avversità i cimbri, da gran montanari, hanno saputo trarre da un’austera economia di sussistenza sufficiente sostentamento tanto che, all’inizio del 1900, Luserna, è arrivata a contare più di mille abitanti.
Dalla metà del 1900 una politica poco attenta alla montagna, che ha investito nei grossi centri del fondovalle a discapito della periferia, ha minato l’esistenza di piccoli e grandi borghi montani; borghi che oggi cercano, prima che l’abbandono diventi irreversibile, un riscatto mediante nuove e antiche professioni.
Questa la Luserna di oggi, una comunità che vuole, attraverso la valorizzazione delle proprie peculiarità linguistiche, culturali e naturalistiche rimettersi in gioco.
La Luserna di oggi crede nel valore dell’essere portatrice di una cultura unica, che può anche rappresentare un valore economico.
In questo contesto non si dimenticano i molti cimbri della diaspora, che mantengono stretti contatti con il paese d’origine, e ai quali viene data la possibilità di occasioni di incontro con chi in paese è rimasto.
Affronta in tutte le sue declinazioni il tema della montagna delle minoranze linguistiche, nel caso specifico degli ultimi cimbri, Fiorenzo Nicolussi Castellan, collaboratore culturale dell’Istituto Cimbro di Luserna/Lusérn.
ingresso libero
organizzazione: CSSEO, e Fondazione Museo Storico