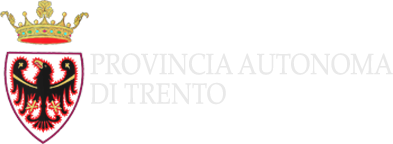I colori della Grande Guerra. Un fotografo austro-ungarico sul fronte italiano 1915-1918
«Un benvenuto a voi che oggi siete qui per ascoltare il racconto della guerra in Italia». Richard Synek, fotografo «per ordine dello Stato Maggiore austriaco sui luoghi della feroce guerra mondiale», tornato dall'Italia nella sua Cecoslovacchia costruì con 260 diapositive un racconto da proiettare nelle sale pubbliche del suo paese. Il diario di un viaggio dalla Moravia al Carso, al Tirolo e al Piave che tanti avevano affrontato e che ora avrebbero ripercorso nel ricordo.
Il suo benevenuto «a coloro che ricordano perché hanno partecipato alla guerra mondiale» si caricava di un'attesa particolare, perché gli spettatori sapevano che avrebbero visto una proiezione a colori. Le lastre di vetro erano state infatti dipinte a mano, una a una.
Per la prima volta, dunque, le fredde tinte all'anilina stese sul grigio dell'emulsione fotografica mostrano nei colori «naturali» i soldati della Grande Guerra: la vita in trincea, gli armamenti, i corpi feriti, le file dei morti.
Nell'inalterata distanza degli eventi, i lividi colori di ottant'anni fa ripropongono una guerra che eravamo abituati a vedere in bianco e nero. Anche così al respiro delle foto panoramiche si alternano lo spazio angusto della feritoia e la burocratica esecuzione dei condannati a morte. La nuova luce data dalla varietà cromatica accentua il carattere surreale dei campi di battaglia: ai nostri occhi, questa «guerra a colori» non appare più vera, solo più malinconica.
Dopo il 1918 i temi più presenti ad un'Europa avvilita erano la desolazione delle rovine, le sofferenze dei soldati, il compianto per i caduti. Se l'Austria imperiale aveva voluto la guerra, tutti i popoli della cessata monarchia l'avevano combattuta e pagata con il proprio sangue, in trincea e sul patibolo. I reduci avrebbero ritrovato nelle immagini delle sepolture «Agli amici con i quali hanno combattuto e che non hanno potuto godere del felice ritorno dei loro cari». Anche le immagini dei corpi straziati avrebbero acquistato una funzione nella commemorazione comunitaria.
Negli anni di guerra, il faticoso viaggio verso sud dei soldati austro-ungarici diretti all'Isonzo e al Piave aveva ricalcato il tragitto di tanti europei che nel Settecento e nell'Occento avevano cercato il sole e il Mediterraneo, i cipressi, le piante di alloro. Ma tra il 1915 e il 1918 la geografia del Viaggio in Italia si era irrimediabilmente ristretta: «Gli uditori saranno accompagnati sulle coste tra Opcina, Nabresina, Goriansko, Selo, Trieste, Duino, San Giovanni, Monfalcone, Doberdò, Jamiano, Udine, Oderzo, Vittorio Veneto, Belluno, Cison di Valmarino, Tagliamento, eccetera, fino al Piave» recitava l'invito. «Testimoni, portate le vostre donne, i figli, i nipoti e mostrate loro per l'ultima volta i luoghi nei quali avete combattuto», esortava il banditore.
Anche noi ci accingiamo a guardare
organizzazione: Museo Storico Italiano della Guerra Rovereto onlus - collaborazione dello Stato Maggiore Esercito Ufficio Storico - contributo della Provincia Autonoma di Trento