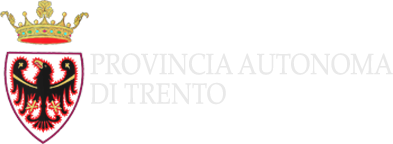Il Bello e le bestie. Metamorfosi, artifici e ibridi dal mito all'immaginario scientifico
Centauri e sirene, fauni e meduse, sfingi e arpie, visioni di sogno e apparizioni da incubo nella cultura visiva occidentale tra passato, presente e futuro.
Dalla mitologia classica alle manipolazioni dell'età contemporanea, l'ibrido come incrocio tra umano e animale, spirituale e carnale, come metafora della realtà e punto di vista sul mondo.
È la grande mostra del Mart per il 2004.
Come ormai è tradizione il Museo di Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto organizza per il periodo di fine anno il suo evento espositivo di maggior rilievo: Il Bello e le bestie. Metamorfosi, artifici e ibridi, dal mito all'immaginario scientifico.
Una mostra-evento - curata da Lea Vergine e Giorgio Verzotti con la direzione progettuale di Gabriella Belli - che partendo dalla seconda metà dell'Ottocento attraversa diverse correnti artistiche e giunge fino alle tendenze più recenti, allargando il suo sguardo indagatore - negli eventi collaterali e nei tanti saggi del catalogo Skira - anche ai territori della letteratura, del cinema, dello spettacolo e a quelli, attualissimi, della scienza e della genetica.
Nelle sale del secondo piano del Mart, dall'11 dicembre 2004 fino all'8 maggio 2005 il pubblico si potrà dunque confrontare con l'universo ambiguo degli ibridi generati dall'incontro fra animalità e umanità: creature legate alla mitologia o ai fantasmi dell'inconscio, "mostri" che da secoli abitano l'immaginario collettivo.
Una scelta di quasi centoottanta opere per abbracciare, in uno sguardo sintetico, due secoli di arte visiva - dal Simbolismo all'estrema contemporaneità - in un affascinante percorso tematico che confronta epoche, stili e contributi concettuali, mettendo a fuoco problematiche secolari: da Arnold Böcklin a Gustave Moreau; da Auguste Rodin a Franz Von Stuck, Matthew Barney, Max Klinger, Odilon Redon, Giorgio De Chirico, René Magritte, George Grosz, Pablo Picasso, Marc Chagall, Arturo Martini, Alberto Savinio, Paul Delvaux, Francis Bacon, Frida Kahlo, Francis Picabia, Ana Mendieta, Francesco Clemente, Sandro Chia, Mimmo Paladino, Maurizio Cattelan, Louise Bourgeois, Cindy Sherman, Kiki Smith fino ai recentissimi lavori di Aspassio Haronitaki, Giuseppe Maraniello, Luigi Ontani.
Opere straordinarie che provengono da musei e collezioni di tutto il mondo, come il Musèe du Louvre e il Centre George Pompidou di Parigi, il Victoria and Albert Museum di Londra, l'Israel Museum di Gerusalemme, il KunstMuseum di Berna; e ancora il Collection Museum of Contemporary Art di Chicago, la Neue Pinakothek di Monaco, l'Alte Nationalgalerie di Berlino, gli Uffizi di Firenze, le Gallerie d'Arte Moderna di Torino e Roma.
Accanto a questo nucleo portante, un'emblematica selezione di opere più antiche chiamate ad evocare - lungo il percorso espositivo - i riferimenti culturali, gli "archetipi" della produzione artistica occidentale, sul tema del "divenire animale": ecco allora i vasi e i bronzetti greci e romani raffiguranti i protagonisti di miti e leggende, le visioni oniriche delle incisioni di Albrecht Dürer, il bellissimo "Giudizio di Re Mida" di Cima da Conegliano, "L'uccellatore" dell'Arcimboldo, ma anche il "Ritratto di Antonietta Gonzalvus" di Lavinia Fontana, l'"Arrigo Peloso, Pietro Matto e Amon Nano" di Annibale Carracci, le pungenti incisioni del grande Goya.
Cuore pulsante e fonte di ispirazione dell'esposizione è Francis Bacon di cui in mostra saranno presenti tre importanti tele: Chimpanzee, del 1955, Portrait of Michel Leiris, del 1978, e Sphinx. Portrait of Muriel Belcher, del 1979.
Il filosofo Gilles Deleuze ha letto infatti nell'opera del maestro inglese non tanto il dramma esistenziale - da sempre considerato il fuoco della sua ispirazione - ma piuttosto una speciale consapevolezza dell'essere umano, che lo imparenta con l'animalità, la perdita di controllo razionale sulla corporeità e gli istinti.
E proprio partendo da questa idea si è sviluppata la mostra del Mart, laddove il Bello del titolo indica la bellezza ideale, platonica, oggetto di ricerca di artisti ed estetologi, disincarnata, spirituale, assoluta; mentre le bestie rappresentano la molteplicità del reale (segnalata anche dal minuscolo), la non-coscienza, l'opposto di ogni concetto idealistico.
La scelta delle opere in mostra indaga proprio la convivenza dell'alto e del basso, degli opposti fusi nella stessa figura, che si dà quindi come paradosso, costruito su una contraddizione, e che in quanto tale svela un conflitto. Su questo conflitto o paradosso si fonda una parte rilevante della nostra cultura, che orienta la nostra esistenza sul bilico di una realtà altrettanto contraddittoria.
Il progetto espositivo è suddiviso in due grandi sezioni.
La prima è dedicata all'animalità come alterità - con una sezione riservata alla figura dell'uomo-animale come portatore dell' "assoluto naturale" fatto di violenza e sessualità, arcadia e morte; e con una specifica attenzione alle figure che associamo alla "natura matrigna": la Sirena, la Medusa, la Sfinge e il Minotauro, "mostri" di cui la mitologia prima e la letteratura poi ci hanno dato numerosi ed alti contributi.
L'altra sezione, è dedicata alla vicinanza, alla prossimità dell'animalità come parte di noi, specchio della nostra schizofrenia di uomini "civilizzati".
Il rapporto umanità-animalità qui si fa stringente: tocca le deformazioni e le mutazioni fino al tema, come dicevamo attualissimo,delle manipolazioni genetiche; i luoghi dell'inconscio inteso come un enigma che si può sciogliere, anche se a costo di faticose introspezioni, o i territori della razionalità dove l'enigma dell'uomo-animale diventa metafora per veicolare un discorso critico, latamente politico, sulla realtà e il suo assetto sociale.
Tutto questo delinea uno scenario abbastanza drammatico nei rapporti fra uomo e animale, descritto anche in catalogo da punti di vista diversi grazie ai contributi di storici dell'arte come Gabriella Belli, Markus Müller, Maria Grazia Tolomeo Speranza, Lea Vergine, Giorgio Verzotti, Francesco Zambon, ma anche di storici, (Giuseppe Olmi) etologi (Giorgio Celli), microbiologi (Enrico Magliano), psichiatri (Giacomo Di Marco), storici della scienza (Nikolaas Rupke e Karen Wonders), sociologi (Renato Mazzolini e Massimiano Bucchi), storici del cinema (Gian Piero Brunetta), scrittori e poeti (Edoardo Sanguineti).
Uno scenario che la parte finale della mostra intende sdrammatizzare con immagini che richiamano la fiaba, il carnevale, il comico, il grottesco.
Tema dunque ambiguo e insidioso, quello di questa mostra, giacché il rapporto dell'umano col bestiale è sgomentante e malato. Ma tema, tuttavia, affascinante e stimolante perché conduce in un mondo dove agisce il "perduto dell'uomo", che, come dice Lea Vergine, è quella istintualità smarrita nel corso della cosiddetta civilizzazione.
organizzazione: Mart