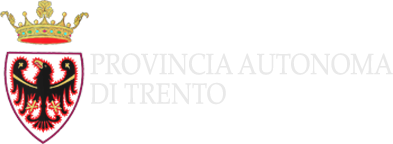Il maestro di cappella
Trento Estate 2009
concerti e musica
Complesso Corelli
Il maestro di cappella
di Domenico Cimarosa (1749-1801)
libretto di autore ignoto
Intermezzo in musica in un atto
Sei violini, due viole, due violoncelli, un contrabbasso, due flauti, due oboi, due corni, un fagotto, un clavicembalo-fortepiano, un baritono-basso
Il maestro di Cappella è un intermezzo comico composto da Domenico Cimarosa, probabilmente tra il 1786 e il 1793 basato su un libretto di produzione ignota. Loperina è unica nel suo genere in quanto diversamente da tutti gli altri intermezzi settecenteschi, vi è la presenza di un solo cantante, il maestro di cappella appunto. Il programma sarà completato da altri brani del compositore napoletano come il sestetto in sol maggiore per fortepiano, fagotto, due violini, viola e violoncello e la Sinfonia in si maggiore per 2 oboi, 2 corni e archi.
Programma:
Omaggio a Franz Joseph Haydn nel 200° anno dalla morte
J.Haydn (1732 1809)
Sinfonia n.16 in SIb Maggiore
Allegro. Andante moderato. Finale, allegro.
***
D.Cimarosa (1749 1801)
Il maestro di cappella
Intermezzo in musica in un atto per basso-baritono e orchestra
Organico:
BASSO-BARITONO: Mattia Nicolini
VIOLINI: Andrea Ferroni*, Viktoria Gőgele, Stefano Roveda*, Sergio La Vaccara
VIOLE: Klaus Manfrini*, Nicola Fadanelli
VIOLONCELLO: Ivo Brigadoi
CONTRABBASSO: Norbert Zőggeler
FLAUTO: Ornella Gottardi
OBOI: Federica Azzali*, Fabrizio Dissegna
CORNI: Stefano Rossi*, Roberto Garniga
FAGOTTI: Igor Delaiti*, Francesca Sacco
CLAVICEMBALO: Chiara Minali
(*): prime parti.
Questo celebre lavoro è problematico già a partire dalla sua destinazione. La definizione di intermezzo è puramente ipotetica, poiché la presenza di un solo personaggio lo renderebbe un unicum in quel genere di spettacolo teatrale; potrebbe trattarsi anche della rielaborazione e dellampliamento di unaria per basso e orchestra, oppure di una cantata comica. Incerta è altresì la data di composizione, che dovrebbe aggirarsi tra il 1786 e il 1793. Sicuramente il pezzo incontrò subito il gusto del pubblico: già nel 1810 veniva infatti pubblicato a Lipsia.
Un maestro di cappella sta provando con la propria orchestra; dichiara di volervi eseguire unaria in «stil sublime», appellandosi allautorità degli antichi maestri («che sapevano tanto»). Quando finalmente laria inizia, il risultato è disastroso: ogni strumento entra al momento sbagliato, costringendo il maestro a canticchiare personalmente ogni parte finché ciascun strumentista non labbia imparata. Collaudata con successo la compagine orchestrale, ci si cimenterà in un «gran morceau » di sicuro effetto.
La gustosa parodia di un compositore settecentesco alle prese con i suoi esecutori prende le mosse da un libretto costruito sul largo impiego di termini tecnici, che suggeriscono così realisticamente la caricatura del maestro di cappella. Il lavoro si ricollega a un filone metateatrale particolarmente frequentato nel Settecento (ricordiamo ad esempio La Dirindina di Domenico Scarlatti, La canterina di Haydn, Der Schauspieldirektor di Mozart), cui Cimarosa stesso aveva contribuito proprio in quegli anni con ? Limpresario in angustie (1786). La struttura musicale dellopera è particolarmente interessante: dopo un recitativo accompagnato che introduce le prove, laria propone, nel quadro di un fantasioso disordine, una sorta di campionario dei timbri strumentali dellorchestra dellepoca. In una terza fase, le varie parti proposte dal maestro vengono dapprima intonate dalle diverse sezioni orchestrali e quindi integrate - mentre la voce tace - in una pagina di grande vigore sinfonico, del tutto degna di comparire in apertura di unopera coeva. Unultima aria conclude gioiosamente queste problematiche prove
organizzazione: Comune di Trento - Centro Servizi Culturali S. Chiara