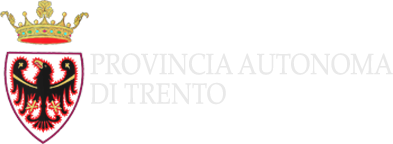Il vino di Dioniso. Dei e uomini a banchetto
La mostra si propone di illustrare, attraverso 3 sezioni e oltre centocinquanta reperti di raffinata bellezza provenienti da siti archeologici lucani e facenti parte della ricca collezione del Museo Archeologico di Metaponto, diverse tematiche legate al consumo del vino nell'antichità, quali le tecniche di produzione, di conservazione e di trasporto di questo prezioso prodotto alimentare, ma anche la valenza sociale del banchetto e del simposio e i significati rituali e cerimoniali dell'assunzione del vino, con particolare attenzione alla sfera del culto di Dioniso, la divinità preposta alle attività della vinificazione e distribuzione sacrale della bevanda alcolica.
I materiali archeologici in mostra si collocano in un arco cronologico compreso fra la fine dell'età del Bronzo e l'epoca imperiale romana
L'esposizione roveretana presenta, rispetto alle versioni che la hanno preceduta presso il Museo di Santa Maria della Scala a Siena e presso il Museo del Castello di Lerici, una piccola ma significativa selezione di reperti appartenenti alle collezioni archeologiche del Museo Civico. Accanto al vasellame proveniente dall'area magnogreca figura infatti in primo luogo il cratere attico a colonnette a figure rosse con scena dionisiaca, che fu donato dalla Regione Sicilia all'istituzione roveretana in cambio della biblioteca privata di Paolo Orsi. Sono poi presenti alcuni reperti di provenienza locale che illustrano i temi del commercio e dell'uso del vino, della mensa e dell'attività agricola in epoca romana nel territorio lagarino. Un insieme di anfore di età romana provenienti da Aquileia e acquisite dal museo nella seconda metà dell'800, infine, illustra i mezzi di trasporto e di commercializzazione di prodotti alimentari allo stato liquido, quali l'olio e il vino, di fondamentale importanza nella dieta alimentare degli antichi Romani
Progetto scientifico e cura della mostra Maria Luisa Nava Antonio de Siena
Collaborazione scientifica di Gianni Ciurletti Franco Finotti Barbara Maurina
Progettazione dell'allestimento Giovanni Marzari Gianluca Dossi
Realizzazione dell'allestimento Servizio edilizia pubblica e viabilità - Comune di Rovereto
Referenze fotografiche Mario Calia Alessandro cardani Nicola Figliuolo Giulio Malfer Angelo Romaniello
Restauri Giuseppe Basile Florence Caillaud Giuliano De Asmunidus Maria Rosaria Germano Michele Martorano Antonio Pace Alessandro Pesare Vita Quattromini Antonio Sabatella
Allestimento e Grafica Alessio Periotto
Collaborazione tecnica Marco Nave
Ufficio Stampa Claudia Beretta
Progettazione grafica catalogo Jack Blutharsky
Stampa: Edizioni Osiride - Rovereto (TN)
Aperitivo con Dioniso
Incontri a margine della mostra ore 17.30
15/6 Dioniso e lo straniero che è in noi (fra teatro e psicanalisi): Luca Dorizzi e Luisa Lisson
22/6 Il vino di Dioniso. simbolismo e ritualità: Nadia Testa
7/9 Alcol e bevande inebrianti fra le culture tradizionali: Giorgio Samorini
14/9 La musica del convivio: Roberto Melini - presenta Gianfranco Grisi
21/9 Il vino: produzione, commercio e consumo nell'Italia romana: Barbara Maurina segue aperitivo offerto da Vivallis
IL VINO DI DIONISO. DEI E UOMINI A BANCHETTO ... A ROVERETO
La stagione espositiva 2005 del Museo Civico si apre in febbraio con una mostra archeologica che presenta straordinari reperti
di BARBARA MAURINA
Il Vino di Dioniso, Dei e uomini a banchetto. Già allestita fra il 2002 e il 2004 presso il Museo di Santa Maria della Scala a Siena e presso il Museo del Castello di Lerici (La Spezia), l'esposizione, promossa dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici della Basilicata e curata da Antonio De Siena, è stata messa a punto a Rovereto grazie alla collaborazione del Museo del Castello di Lerici e della Soprintendenza per i Beni Archeologici della PAT.
L'allestimento si propone di illustrare, attraverso tre sezioni e oltre centocinquanta reperti provenienti da siti archeologici lucani e facenti parte della ricca collezione del Museo Archeologico di Metaponto, tematiche legate al consumo del vino nell'antichità, quali le tecniche di produzione, di conservazione e di trasporto, ma anche la valenza sociale del banchetto e del simposio e i significati rituali e cerimoniali dell'assunzione del vino, con particolare attenzione alla sfera del culto di Dioniso, la divinità preposta alle attività della vinificazione e distribuzione sacrale della bevanda alcolica.
Fra i manufatti in mostra figurano oggetti pertinenti alla suppellettile da mensa (spiedi, treppiedi, lucerne e kottaboi) e vasellame di ceramica e di metallo (crateri, anfore, oinochoai, kylikes, kantharoi, rhytoi), in un arco cronologico compreso fra la fine dell'età del Bronzo e l'epoca imperiale romana. I numerosi vasi decorati a figure nere e a figure rosse, in particolare, rappresentano la pregiata produzione ellenica che soprattutto fra il VI e il IV secolo a.C. venne importata dalle comunità italiche. A partire dal VII secolo, infatti, i coloni greci diffusero anche in Magna Grecia gli usi e costumi della madrepatria e con essi il consumo del vino: già nei poemi omerici il vino rappresenta uno dei momenti più significativi delle forme di convivialità delle aristocrazie greche. Nei corredi funerari di maggior prestigio delle élites anelleniche dell'Italia meridionale, come pure presso gli Etruschi, vengono così introdotti i raffinati vasi in bronzo per versare (oinochoai) e per bere (skyphoi), e, più tardi, il cratere, il vaso vinario per eccellenza, consacrato a Dioniso, che mescola il vino puro con l'acqua, al fine di renderlo bevibile per gli uomini: non è un caso che fra le immagini che decorano questi recipienti, compaiano frequentemente raffigurazioni dionisiache e scene di banchetto. La terza sezione della mostra è dedicata nello specifico al dio e al suo seguito, il tiaso bacchico, formato menadi e satiri, attraverso lesposizione di ceramiche di origine attica e italiota decorate da temi votivi.
L'esposizione roveretana presenta, rispetto alle versioni che la hanno preceduta, una piccola ma significativa selezione di reperti appartenenti alle collezioni archeologiche del Museo Civico. Accanto al vasellame proveniente dall'area magnogreca figura infatti il cratere attico a colonnette a figure rosse con scena dionisiaca, donato dalla Regione Sicilia all'istituzione roveretana in cambio della biblioteca privata di Paolo Orsi. Sono poi presenti alcuni reperti di provenienza locale (Isera, Rovereto), i quali illustrano i temi del commercio e dell'uso del vino, della mensa e dell'attività agricola in epoca romana nel territorio lagarino. Un insieme di anfore di età romana provenienti da Aquileia e acquisite dal museo nella seconda metà dell'800, infine, illustra i mezzi di trasporto e di commercializzazione di prodotti alimentari allo stato liquido, quali l'olio e il vino, di fondamentale importanza nella dieta alimentare degli antichi Romani.
Sappiamo infatti dalle fonti antiche che la vite era conosciuta a Roma fin dall'epoca delle XII tavole, il primo testo giuridico romano risalente al V secolo a.C. Effettivamente, a partire da quell'epoca, per il tramite dei Greci e degli Etruschi anche nel mondo romano incominciò a diffondersi l'uso del vino e iniziarono a svilupparsi le aziende vinicole locali.
È possibile che la coltivazione della vite fosse praticata già in età romana anche nel territorio lagarino. Questo potrebbe suggerire, tra l'altro, il ritrovamento, nello scavo della villa di Isera, di una falx arboraria, un tipo di roncola considerata da Catone indispensabile nella coltivazione della vite.
organizzazione: Museo Civico di Rovereto - in collaborazione con Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Soprintendenza per i Beni Archeologici della Basilicata, Soprintendenza per i Beni Archeologici della PAT, Museo del Castello di Lerici La Spezia - con il sostegno di Vivallis Viticoltori in Vallagarina