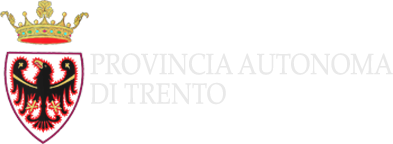La città e l'archeologia del sacro
La città e l'archeologia del sacro.
Il recupero dell'area di Santa Maria Maggiore
Mostra a cura di Maria Teresa Guaitoli, Elisa Lopreite
Sarà inaugurata venerdì 29 novembre alle ore 18.30 l'attesa mostra La città e l'archeologia del sacro. Il recupero dell'area di Santa Maria Maggiore, organizzata dal Museo Diocesano Tridentino in collaborazione con il Dipartimento di Archeologia dell'Università di Bologna e l'Ufficio Beni Archeologici della Soprintendenza per i beni architettonici e archeologici della Provincia Autonoma di Trento. La mostra si colloca nell'ambito dell'iniziativa Anno2013MuseInrete promossa da AMEI (Associazione Musei Ecclesiastici Italiani) in occasione dell'anniversario dell'Editto di Costantino (313 d. C.), noto anche come Editto di Milano, un documento di straordinaria modernità che, concedendo la libertà di culto in tutto l'impero, inaugurava un periodo di tolleranza religiosa e di grande innovazione politica e culturale.
Dopo il difficile intervento di scavo condotto all'interno della chiesa di Santa Maria Maggiore tra il 2007 e il 2011, la mostra propone per la prima volta al grande pubblico i reperti rinvenuti nel sottosuolo della chiesa, offrendo l'opportunità di conoscere gli esiti di un complesso lavoro di ricerca che ha permesso di restituire alla città una fase importante e poco nota della sua storia. L'esposizione consente inoltre di contestualizzare le testimonianze archeologiche venute alla luce durante lo scavo, integrando le novità emerse dallo studio di questi reperti con le conoscenze già acquisite nei precedenti interventi effettuati sia nell'area di Santa Maria Maggiore che in altri luoghi della città. Mediante l'esposizione di reperti particolarmente evocativi, alcuni dei quali riferiti agli altri luoghi di culto, come la Basilica di San Vigilio, Sant'Apollinare, la chiesa del Doss Trento, San Lorenzo, l'esposizione fornisce al visitatore un'esaustiva panoramica dei siti archeologici cittadini afferenti la Trento paleocristiana.
Il percorso si apre con un richiamo al celebre Editto di Costantino e alla complessa e articolata fase di transizione fra paganesimo e Cristianesimo, testimoniata in mostra da una serie di monete risalenti al IV-V secolo d. C., recanti temi iconografici diffusi in epoca costantiniana. Vengono esposti inoltre significativi reperti che testimoniano l'eterogeneo contesto religioso della regione, ancora fortemente permeato dai culti riferibili alle principali divinità romane.
La successiva sezione intende inquadrare il contesto economico, sociale e militare della Trento tardoantica. A partire dalla seconda metà del III secolo d.C., Tridentum assunse un ruolo strategico a difesa dei confini, diventati più vulnerabili a causa delle mire espansionistiche di popolazioni barbariche. Si collocano in questo periodo storico alcuni importanti reperti quali i complementi dell'abbigliamento e dell'armamento di militari e di funzionari dell'amministrazione. Altre suppellettili provenienti dall'Africa e dal Medio Oriente testimoniano la dimensione cosmopolita della città, attraversata da traffici commerciali internazionali e dal passaggio di cittadini orientali a Trento.
Dopo questa premessa, il focus dell'esposizione si sposta sugli scavi effettuati nel sottosuolo della chiesa di Santa Maria Maggiore. L'indagine archeologica ha permesso di ipotizzare che la zona in età romana (fine del I secolo d.C.) fosse occupata da un impianto termale pubblico del quale restano solo alcune tracce; in mostra sono presentati materiali lapidei appartenenti alle strutture e all'arredo di tali ambienti. Lo scavo, inoltre, ha evidenziato il definitivo abbandono dell'impianto romano tra IV e V secolo d.C. e, di conseguenza, un mutamento di funzione dell'area sulla quale sorgerà l'ecclesia. Per introdurre il tema della topografia cristiana dell'antica Tridentum, la mostra propone ai visitatori un manoscritto con la Passio Sancti Vigilii, un testo del VII-VIII secolo che narra la vita di San Vigilio combinando notizie tratte da fonti originali con eventi leggendari. La Passio documenta l'esistenza di due distinti poli, l'ecclesia e la basilica: l'ecclesia - posta presumibilmente nell'area di Santa Maria Maggiore - è la chiesa episcopale eretta dentro le mura, sede prioritaria della comunità; la basilica è l'edificio sorto al di fuori delle mura romane sulle tombe dei martiri Sisinio, Martirio e Alessandro e del santo patrono Vigilio.
Partendo dai risultati dello scavo, vengono di seguito esplicitate le ipotesi afferenti le fasi costruttive dell'edificio di culto sorto nell'area di Santa Maria Maggiore, con particolare attenzione alle trasformazioni dell'area presbiterale e all'evoluzione dell'apparato decorativo-architettonico. L'attenzione si concentra sulla ricostruzione della recinzione presbiterale (detta pergula) che divideva l'area riservata al clero da quella destinata ai fedeli: un suggestivo videoarredo illustra in maniera chiara e intuitiva le principali modifiche apportate in quest'area. La mostra propone quindi un confronto tra gli elementi lapidei rinvenuti negli scavi di Santa Maria Maggiore e i reperti della Basilica Paleocristiana di San Vigilio, portati alla luce durante la campagna archeologica condotta da mons. Rogger negli anni Settanta del Novecento. In questa sezione trova spazio un approfondimento (affidato ad una postazione multimediale) relativo alle fasi edilizie, dalle origini al XII secolo, della Basilica paleocristiana di San Vigilio, il luogo più importante della cristianità regionale e della Chiesa di Trento.Conclude il quadro della Trento paleocristiana un piccolo ma significativo nucleo di oggetti provenienti da altre chiese di Trento, precisamente dalla basilica di San Lorenzo, dalla chiesa di Sant'Apollinare e dalla chiesa del Doss Trento.
All'ultima sezione è affidata il completamento della ricostruzione delle fasi edilizie di Santa Maria, con le modifiche impresse all'edificio tra il X secolo e la fine del XIII secolo, e il racconto delle fasi dello scavo visualizzato tramite la proiezione di un video. Le indagini archeologiche hanno portato alla luce complessivamente un centinaio di tombe di cui 44 di epoca medievale (XI-XV secolo) e 56 databili fra gli anni del Concilio di Trento e il XIX secolo. Vengono infatti esposti interessanti reperti connessi all'ambito devozionale (medagliette religiose, crocifissi e grani di rosario) e alcuni elementi relativi al vestiario e all'ornamento personale dei defunti, quali bottoni, spilli e spilloni, anelli d'oro e di bronzo.
organizzazione: Museo Diocesano Tridentino - Arcidiocesi di Trento - Dipartimento di Storia Culture Civiltà Sezione di Archeologia dell'Università di Bologna - Ufficio Beni Archeologici della Soprintendenza per i beni architettonici e archeologici della Provincia Autonoma di Trento