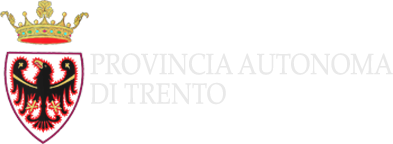Montagna arte scienza mito
In dicembre, in Trentino, inizia un viaggio in montagna davvero emozionante.
In una straordinaria mostra organizzata nella nuova sede del Museo di Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto e nella sede trentina di Palazzo delle Albere, sarà possibile ripercorrere attraverso l'opera di artisti e scienziati la storia di un grande mito: quello della Montagna.
Sei secoli di arte e di scienza a confronto, dal Cinquecento ad oggi, in un percorso articolato nelle 35 stanze del Mart di Rovereto e di Trento, mostreranno quale debito l'arte abbia stretto con il sapere scientifico, e, viceversa, quanto gli scienziati abbiano corrisposto alle geniali intuizioni degli artisti per tracciare la storia del grande mistero della nascita delle montagne.
Oltre 400 opere - tra dipinti, sculture, disegni, incisioni, libri rari, modelli, strumenti scientifici originali, oggetti di curiosità - condurranno il visitatore alla scoperta di quelle verità scientifiche che in poco più di cinque secoli hanno trasformato l'orrore e la paura per queste inspiegabili "deformazioni" della terra in un fenomeno positivo dell'evoluzione naturale. Nello stesso tempo mostreranno come gli artisti - tra incantamenti e registrazioni oggettive della realtà, tra sublime e romantico - hanno via via rappresentato questo tema: sicuramente uno dei più affascinanti soggetti dell'arte occidentale di tutti i tempi.
Si spazia da Dürer a Friedrich, da Cézanne a Warhol, da Goethe a Humboldt e De Saussure, da Galileo Galilei fino alle più recenti teorie scientifiche, grazie ai prestiti ottenuti dai musei di tutto il mondo: dal Musée du Louvre di Parigi alla Tate Modern di Londra, dal British Museum alla National Gallery of Art di Washington, dall'Hermitage di San Pietroburgo alla Nasjonalgaleriet di Oslo, dal Museum am Ostwall di Dortmund, all'Oeffentliche Kunstsammlung di Basilea, dallo Staatliche Museen di Berlino al Von der Heydt Museum di Wuppertal, dalla Menil Collection di Houston allo Stedelijk Museum di Amsterdam, dal Museo del Prado di Madrid, alla Guggenheim Collection di New York, dalla Galleria degli Uffizi a quella di Arte Moderna di Milano.
La mostra, curata da Anna Ottani Cavina e Paola Giacomoni, con la direzione progettuale di Gabriella Belli e un comitato scientifico internazionale, si suddivide in 4 grandi capitoli.
L'intuizione e la ricerca scientifica ovvero il passaggio da un approccio verso la montagna ancora immaginifico - proprio della tradizione tardo-bizantina e dei pittori fiamminghi - alla riflessione scientifica critica, avviata da Galileo. Nel mezzo i primi tentativi di rappresentazione veritiera della natura di Albrecht Dürer, di cui saranno esposte al Mart ben tre eccezionali opere, accanto al famoso "Trattato della Pittura" di Leonardo da Vinci, nella trascrizione di Francesco Melzi della metà del XVI secolo.
La scoperta della montagna. Dal sublime al Romantico: una Montagna che attrae e respinge, che esalta ed impaurisce. Nel corso del XVIII secolo il Grand Tour la vedeva come il luogo per eccellenza dello stupore e della meraviglia. Un'interpretazione che trova espressione nei quadri inglesi di Turner, Cosenz, Wright of Derby, nella pittura tedesca e francese dell'700 con Füssli, Wolf, Volaire, Hackert, Martin e Doré, per arrivare alla visione romantica, ottocentesca di Friedrich, Carus, Schinkel, a quella eroica di tanta pittura nordica e a quella, esposta per la prima volta in Italia, dei grandi paesaggisti americani dell'epoca. Gole, vulcani, cascate e ghiacciai diventano soggetti prediletti dei pittori della montagna, di cui ora si accettavano l'origine caotica e il disordine pur senza riuscire ancora a catalogarlo e a classificarlo. Su tutti, un personaggio emblematico: John Ruskin, espressione del convergere di interessi scientifici e visionarietà artistica.
La smaterializzazione della Montagna. Dal simbolismo all'espressionismo ci conduce in pieno '800 fino agli inizi del XX secolo. Le cognizioni scientifiche positiviste inducono gli artisti ad un duplice approccio: da un lato la rappresentazione realistica, attenta al dettaglio così come all'insieme della veduta - virtuosa nel far vibrare aria e luce sulla tela, grazie ai principi scoperti dalla fisica del tempo - dall'altro la sperimentazione, che può essere affrontata liberamente, ora che le Scienze hanno svelato i misteri della Montagna. Da Cézanne a Nolde, da Hodler a Münch, da Moser a Vallotton si torna alla visionarietà fantastica, dove il reale si perde, o appunto si "smaterializza" in una dimensione puramente concettuale. Ora la Montagna - come nei capolavori di Kandinsky, Jawlensky, Kirchner - diviene simbolo della condizione dell'uomo contemporaneo, del suo richiamo disperato, senza risposta.
La negazione della Montagna. L'arte contemporanea ci porta al periodo successivo alla 2ª Guerra Mondiale. L'arte si fa critica radicale dell'esistente, giungendo ad estremizzare le posizioni avanguardiste di inizio secolo. Ecco allora l'art brut di Jean Dubuffet, pittura fatta di materia, o le icone pop che reinterpretano la montagna con spirito ironico, ma anche allarmante, di un Andy Warhol o, per l'Italia, di un Mario Schifano. Nel frattempo la scienza scrive un'ulteriore capitolo nella sua indagine sulla nascita del mondo, con le teorie della Deriva dei continenti e della Tettonica a placche. Ora non si tratta più di rappresentare la natura, ma di farne esperienza. I nuovi linguaggi dell'arte contemporanea si prestano a questa "immissione" dell'artista nella natura, come dimostra l'uso di pietre e legni in molti lavori. Questo, tuttavia, è un approccio di breve durata, come dimostrano le opere di Merz, Rainer, Baselitz, e Richter. L'esperienza sembra impossibile negli anni '90 ove il senso della natura viene schiacciato dall'allarme verso uno sfrenato consumismo e il collasso ambientale. Le opere dei grandi protagonisti della scena artistica contemporanea, in questa straordinaria "kermesse", non potevano mancare, e molti lavori saranno realizzato dagli artisti appositamente per il Mart.
organizzazione: Mart - Università degli Studi di Trento - Museo Tridentino di Scienze Naturali - Castello del Buonconsiglio