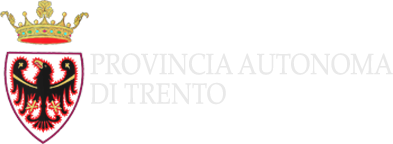Parole come armi
Parole come armi
La propaganda italiana nella Prima guerra mondiale
L'arma nuova della propaganda
La Grande Guerra non si combatté solo nelle trincee, nei mari e nei cieli. Per la prima volta campo di battaglia divenne anche la mente e il cuore di ciascun soldato, il mondo dei suoi pensieri, delle sue certezze e delle sue speranze, delle sue ansie e dei suoi bisogni.
I Comandi militari compresero che in quella guerra si doveva come mai prima rafforzare lo spirito combattivo dei propri soldati e contemporaneamente indebolire quello nemico; assicurarsi la lealtà dei propri reparti e allo stesso tempo espugnare la mente degli avversari per seminarvi il dubbio e minare la determinazione a combattere.
Fu una guerra parallela a quella tradizionale, condotta con armi, strategie e battaglie nuove. Larma fu la parola, la strategia fu la propaganda; con esse si cercò di agire sul nemico, di cambiargli la visione delle cose, di mostrargli la guerra e la pace in una luce nuova: la prima senza speranza, la seconda più desiderabile della vittoria. E non per spirito pacifista, ma per disarmarlo, per spingerlo a ribellarsi ai propri comandanti, per trasformarlo nellautore della propria sconfitta.
La mostra rivela questa vera e propria guerra di parole scatenata anche sul fronte italo-austriaco, ne illustra la pianificazione, gli sviluppi e gli esiti, mostra gli strateghi e le armi impiegate volantini, giornali, manifesti in quella che fu la più estesa battaglia della propaganda fino ad allora scatenata.
In mostra volantini, manifesti, locandine, vignette provenienti dal Fondo Propaganda conservato nellArchivio del Museo della Guerra di Rovereto, costruito a partire dal materiale donato al Museo nellaprile del 1922da Tullio Marchetti del Servizio Informazioni della 1a Armata.
La mostra è organizzata in 4 sezioni:
la propaganda in Italia: promotori, organizzazione, strumenti;
la propaganda dellEsercito italiano contro le truppe austro-ungariche, dedicata al tema delle nazionalità;
la propaganda dellEsercito austro-ungarico verso i soldati italiani;
gli effetti della propaganda: i disertori, i prigionieri, le Legioni cecoslovacca, polacca e romena, la nascita dei nuovi stati nazionali dalla dissoluzione dellImpero austro-ungarico
La propaganda in Italia
Ben pochi nell'Italia del 1915 erano disposti a considerare la propaganda un mezzo di azione politica e ad utilizzarla come strumento decisivo per alimentare e conservare il consenso alla guerra.
In realtà, di fronte alle diffuse manifestazioni di freddezza e di ostilità rilevabili un po' ovunque nella società italiana, la propaganda si rivelò - accanto alla repressione - il canale principale per influenzare l'opinione pubblica.
Sorsero Associazioni, Comitati, Leghe, Unioni per promuovere il sostegno alla guerra e all'esercito. La propaganda occupò ogni spazio disponibile: furono stampati milioni di cartoline con motivi patriottici; vennero diffusi centinaia di migliaia di volantini e di opuscoli per illustrare le ragioni della guerra, furono affissi ovunque manifesti con immagini di donne indifese e di soldati che facevano fronte al nemico, vennero prodotti film e diffuse fotografie su riviste e pubblicazioni.
Si trattava di convincere gli italiani che i sacrifici erano necessari, che l'Italia non era succube degli alleati inglesi e francesi, che la guerra riguardava l'intera nazione e non solo le classi benestanti.
Soprattutto dopo il trauma di Caporetto, come reazione al senso di sconfitta che rischiava di contagiare ogni segmento della società italiana, la propaganda divenne veicolo di messaggi finalizzati a diffondere parole d'ordine e slogan.
La propaganda dell'Esercito italiano e il tema delle nazionalità
Durante la Grande Guerra i servizi Informazioni italiani dedicarono alle truppe nemiche una martellante campagna di messaggi volti a togliere loro le motivazioni a combattere. Particolarmente efficace risultò linvio di notizie tratte dalla stampa austro-ungarica che segnalavano le difficili condizioni di vita delle popolazioni civili, notizie che offrivano lo spunto per accusare gli austriaci e gli ungheresi di volontà persecutoria verso le diverse nazionalità dellImpero.
Nellultimo anno di guerra il tema delle nazionalità diventò centrale nella propaganda italiana.
L'8 aprile 1918 si svolse a Roma il Congresso delle nazionalità oppresse dell'Austria-Ungheria e il 15 maggio venne costituita la Commissione centrale di propaganda sul nemico. Sempre più numerosi divennero i proclami e gli appelli che, enfatizzando le pretese egemoniche della Germania e dell'Austria-Ungheria, indicavano, nelle diverse lingue, le ragioni di ribellione verso i due Imperi.
La distribuzione dei materiali di propaganda avveniva attraverso gli aerei, il lancio di granate inerti e di razzi, o attraverso pattuglie di soldati che si avvicinavano alle linee nemiche.
Dal 15 maggio al 1 novembre 1918 la Commissione diffuse 755 stampati per un totale di 70 milioni di copie, spingendo i lanci fin nelle retrovie nemiche, fino nei cieli di Lubiana, Zagabria e Vienna.
Quando, nellautunno 1918, lesercito austro-ungarico crollò sotto la pressione italiana indebolito da lacerazioni e dissidi, fu chiaro che la sua resistenza era stata compromessa anche da quella nuova, corrosiva forma di guerra.
Il catalogo
Il catalogo della mostra presenta un saggio di Marco Mondini (Larma delle parole. La propaganda verso il nemico nellItalia della Grande Guerra) dedicato alla nascita e allorganizzazione delle attività di propaganda nellEsercito italiano ed una selezione di volantini italiani rivolti ai soldati delle diverse nazionalità austro-ungariche (Cecoslovacchi, Polacchi, Ungheresi, Serbi Croati e Sloveni, Romeni, Austriaci). I materiali provengono dal fondo Propaganda conservato nellArchivio del Museo della Guerra di Rovereto. I documenti sono accompagnati da schede informative.
Marco Mondini, Parole come armi. La propaganda contro il nemico nell'Italia della Grande Guerra, Museo Storico Italiano della Guerra, Rovereto 2008
organizzazione: Museo Storico Italiano della Guerra