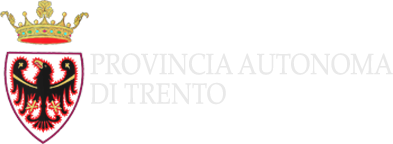Nella seconda metà degli anni Sessanta, il mondo occidentale, che aveva attraversato una fase di grande sviluppo e di diffuso benessere, sembrò quasi avviarsi verso un periodo di "frana", come la definisce sempre Hobsbawm, dovuto all'inasprimento della guerra del Vietnam, allo scoppio di altre guerre come quella dei "sei giorni" tra paesi arabi ed Israele (1967), alla cosiddetta "contestazione studentesca" e alla "primavera di Praga" repressa nel sangue (1968), alla protesta operaia dell'autunno caldo (1969), al dopoconcilio e all'inizio della "strategia della tensione" (1969): tutti fenomeni legati al processo di trasformazione sociale e di mutamento culturale che aveva coinvolto soprattutto il mondo a capitalismo avanzato dell'Occidente.
Per alcuni di questi cambiamenti, Trento si trovò in prima linea. La scelta dell'industrializzazione aveva provocato gravi dissesti nell'economia agricola della provincia. Nel febbraio 1964 c'era stata anche una clamorosa protesta di quattro mila contadini per il crollo del prezzo delle patate. Scesi dalle valli, erano sfilati per le vie di Trento scagliandosi contro la Regione, accusata di scarsa sensibilità nei confronti dei problemi del mondo agricolo. Ma anche gli operai trentini non potevano dichiararsi soddisfatti. La crisi economica del 1965 e l'inflazione avevano fatto svanire poco per volta il loro sogno di benessere, mentre i sindacati organizzavano le prime massicce mobilitazioni di piazza e lo sciopero generale. A Trento furono gli operai della SLOI (una fabbrica a nord della città che produceva il tossico piombo tetraetile) a muoversi per primi, seguiti dai colleghi della Michelin e poi via via dagli operai delle fabbriche di Rovereto.
Ma la società trentina esprimeva inquietudini non solo per le difficoltà economiche. Il Concilio Vaticano II si era concluso da poco tempo e, assieme al fervore del rinnovamento, aveva provocato anche episodi di contestazione all'interno della Chiesa. A Trento un gruppo di questi "cattolici del dissenso" aveva dato vita nel 1966 alla rivista "Dopoconcilio", dove si andava definendo la nuova figura del "laico-cristiano", impegnato soprattutto ad affrontare e a discutere i problemi concreti della società, in una prospettiva secolarizzata della religione. Poco per volta sorsero altri gruppi spontanei e comitati di quartiere, animati da giovani cattolici che assumevano posizioni sempre più critiche nei confronti della Chiesa.
Ma l'ambiente più scosso dai fermenti e dalle tensioni di quegli anni fu senza dubbio quello dell'università e della scuola. Le proteste innescate contro la legge 2314 della riforma universitaria proposta dal ministro Luigi Gui (nei loro volantini gli studenti ironicamente scrivevano: "Siamo in un mare di gui!"), ben presto si trasformarono in contestazione verso l'istituzione scolastica nella sua globalità, considerata uno strumento di dominio nelle mani del potere "borghese". A Trento si iniziò nel gennaio 1966 ad occupare la facoltà di Sociologia, chiedendo riforme per quanto riguardava il piano degli studi. Negli anni successivi, altre occupazioni si svolsero in maniera più radicale, fino al gennaio 1968, quando l'università trentina rimase occupata per 67 giorni, coinvolgendo anche qualche scuola superiore della città. I trentini, dapprima quasi disinteressati al fenomeno, si risentirono bruscamente soltanto quando il 26 marzo uno studente intervenne platealmente nella cattedrale di Trento per interrompere l'omelia quaresimale del padre predicatore (si parlò allora di "controquaresimale"). Questo episodio scatenò la reazione dei trentini, che qualche giorno dopo assediarono l'università, obbligando gli studenti a porre fine all'occupazione. Da allora però la facoltà di Sociologia venne trasformata dagli studenti in "università critica", nel senso che essa doveva diventare fucina di studio del marxismo in tutte le sue versioni storiche, quasi un laboratorio di pensiero per il cambiamento rivoluzionario della società, svolgendo una "funzione utopica di cervello sociale delle classi subalterne", come scrivevano con il loro inconfondibile linguaggio gli studenti in un loro documento. In altre parole, la contestazione dalle aule di Sociologia passava sulle strade, entrando nelle aule delle scuole superiori o nei capannoni delle aziende industriali e diventando anche lotta armata. Iniziava il periodo più caotico della storia italiana e trentina fino al termine del secolo.